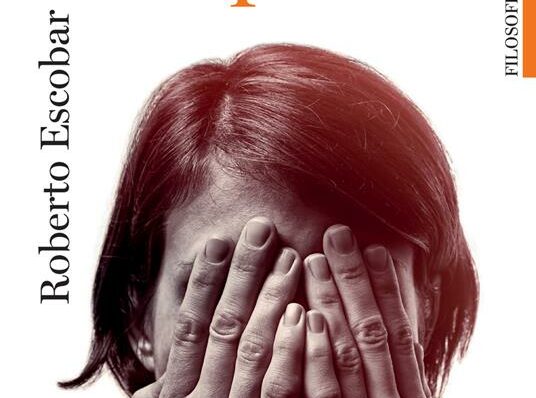Roberto Escobar, I volti della paura, Il Mulino, Bologna 2023, pp. 279.
La paura ha molti volti, ci insegna Roberto Escobar. Volti che assomigliano ad altri, come quelli del terrore o del panico, che non sono però forme della paura ma realtà a sé, nonostante somiglianze ingannevoli (pp. 15-17). Di suo, la paura ha due volti, o volti riducibili a due, come quelli di Giano. Da una parte, c’è il volto che guarda al fuori: alla minaccia che ci assale, ma anche al mistero che stimola alla ricerca e all’avventura. Dall’altra parte, c’è il volto che guarda al dentro, al luogo familiare in cui ci sentiamo al sicuro e verso cui fuggiamo quando gli orizzonti si fanno troppo vaghi e i punti di riferimento abituali svaniscono, come il campanile che il vecchio pastore calabrese di cui narra Ernesto De Martino non sopporta di non vedere più, avendolo visto ogni giorno per tutta la vita (pp. 26-32).
In questo spazio, tra il “fuori” (foris o foras, ciò che sta al di là delle porte chiuse che proteggono chi sta a casa, domi; pp. 88-91) e il “luogo chiuso della sicurezza” (che soffoca, e in cui ci si lascia spesso divorare, pur di non affrontare il “fuori”, da un potere mortifero: pp. 164-167) si consuma, angosciosamente, la vita dell’“animale più indifeso, e il più in pericolo, l’uomo” (p. 42). L’unico animale, per quel che ne possiamo sapere, che ha costantemente davanti a sé il futuro, e nel futuro la propria morte. E nello stesso tempo, come affermano Arnold Gehlen e Clifford Geertz, ha sempre davanti a sé non un campo d’esperienza delimitato, un ambiente vitale specifico in cui ciò che non è immediatamente utile per la vita è semplicemente ignorato, ma un mondo, uno spazio indeterminato e infinitamente variabile in cui sempre di nuovo, e mai una volta per tutte, non solo prelevare risorse, ma ritagliare un senso:
La debolezza dell’animale manchevole si trasforma nella sua opportunità, e la sua povertà nella sua ricchezza. La sua servitù rispetto alla complessità muta e indistinta del mondo produce e fonda la sua signoria nel suo mondo. Ma è una signoria precaria, sempre in pericolo già in sé stessa […] e che perciò deve essere sempre conquistata e riconquistata. In questo senso, l’uomo […] si costruisce. La sua artificialità, il suo essersi fatto compito a sé medesimo, è ora e per sempre la sua natura innaturale. Non esiste un uomo allo stato di natura (p. 50).
Quest’indeterminatezza che costringe l’uomo ad avere un mondo in cui continuamente reinventare sé stesso, lo costringe anche a un costante e complesso rapporto con gli altri. Fornitori di risorse vitali, di informazioni e di modelli, portatori di differenze meravigliose e di diversità inquietanti (pp. 206-210), il rapporto con gli altri è nello stesso tempo condizione di sopravvivenza e sfida mortale. Ed è in questa dimensione della “natura innaturale” dell’uomo che si inscrive, come aspetto centrale della sua artificialità e della sua costruzione di sé stesso, la politica. Di fronte all’indeterminatezza del futuro, alla varietà indominabile del mondo, alla stessa costante complessità e ambiguità dei loro reciproci rapporti,
gli uomini e le donne creano istituzioni, ordinano relazioni e stabiliscono simboli e riti, non solo allo scopo di decidere come e in quali proporzioni distribuire risorse e costi sociali, ma anche e soprattutto di governare e trasformare sia la paura del mondo naturale che li circonda e li minaccia, sia la paura dell’agire opposto e speculare di altri uomini e altre donne (p. 136).
La politica è per eccellenza il “luogo chiuso della sicurezza” alla cui costruzione induce la paura indomabile del “fuori”. Ma, come ogni spazio umano, non è esente da ambiguità e pericoli. Un fondamentale pericolo sta nella stessa ricerca della sicurezza. Se il “fuori”, e il diverso da noi che lo abita, ci minaccia per la sua stessa esistenza, e così ci induce a compattarci, a stare tra di noi, a identificarci nel “noi”, nello stesso tempo ci costringe a dipendere dall’alterità che già in quanto tale ci minaccia e a costituirci come massa compatta che a propria volta minaccia gli abitatori del fuori. Come ben vede Elias Canetti in una delle sue pagine più geniali, questa chiamata a reciproca difesa che ci costituisce come una compatta identità collettiva produce l’identico effetto in chi, nel “fuori”, ci sta di fronte, e produce dunque una solida struttura di conflitto che contiene in sé e continuamente mantiene viva quella stessa minaccia che vuole respingere. È la più solida struttura di massa, la “massa doppia della guerra”.
Specchiarsi in un’altra massa, o nell’altra metà della massa, averla di fronte come minaccia – come “paura” – e allo stesso tempo come modello mimetico, consente alla massa chiusa di confermarsi in sé stessa (p. 132).
Ma così la paura diventa condizione per la sicurezza, avere un nemico diventa necessario per potersi sentire difesi, la struttura d’ordine più solida e duratura si fonda sulla minaccia e continuamente la riproduce. L’ordine non potrebbe mai esistere – non potrebbe mai sapere di esistere – senza un costante disordine ai confini. E dunque lo vuole e lo crea.
Non meno paradossale è la struttura interna della massa, e in particolare il suo centro simbolico. Occorre che la massa abbia un punto di riferimento comune, qualcosa – o qualcuno – in cui tutti si riconoscono e da cui possono desumere la certezza – l’illusoria certezza – di sapere chi sono e di poterlo essere per sempre. Altrettanto necessario del confine minaccioso è il centro potente, da cui si irradiano ordine e senso. Ma l’irradiamento di senso ha esso stesso come motore la minaccia. Il potere, ci dice Canetti, consiste nel sopravvivere. È l’atto di chi respinge da sé una (vera o illusoria) minaccia di morte, spargendo con ciò morte intorno a sé, e in questo spazio di sicurezza che crea allontanando da sé la morte, ma appunto perciò circondandosene da ogni lato, chiama a raccolta i propri seguaci, che per essere suoi compagni nel sopravvivere dovranno essere suoi strumenti nell’uccidere, facendosi dunque uccidere per lui, o quanto meno essendo sempre disponibili ad esporsi per lui a un rischio di morte. E nello stesso tempo, questa morte respinta ai confini ne può sempre riemergere e il “capo”, insieme a tutti i suoi seguaci, minaccia sé stesso e i seguaci con la violenza che tramite loro e a loro danno costantemente esercita. Il capo vive nella, e della, solitudine più spaventosa e più spaventata.
Questa è la sindrome paranoica del capo, uccidere i nemici e allo stesso tempo uccidere o allontanare chi gli sia stato utile un tempo, circondarsi di cadaveri o di servi stupidi – essendo il servilismo stupido una forma attenuata di morte. Strategia di potere o prezzo del potere, in ogni caso, la solitudine è necessaria alla malattia del potente (p. 163).
L’inventiva dell’essere più pericoloso e più in pericolo, come lo chiama Nietzsche, non va però mai sottovalutata. La minaccia che costantemente grava sui confini e sul centro dell’ordine politico, e su di essi grava perché da essi promana, può essere gestita e controllata in un altro modo. Può essere come stabilizzata e congelata all’interno di un meccanismo infinitamente mutevole, una sorta di perpetuum mobile della politica. Ce lo spiega ancora una volta Canetti, nelle pochissime ma dense e geniali pagine che dedica alla democrazia, o meglio, come preferisce dire nel suo costante understatement antiretorico, al “sistema parlamentare”. Il conflitto tra partiti o coalizioni di partiti che determina una maggioranza e una minoranza si risolve – sempre provvisoriamente e sempre rimettendosi in moto – misurando la forza e non la ragione. Esattamente come in guerra. Ma è l’unica guerra senza morti.
In un parlamento democratico, due (o più) partiti si affrontano e si combattono, rinunciando però a uccidere. Che cosa ce li spinge, se non la paura reciproca di fronte al pericolo che li induce alla reciproca prudenza? […] Per quanto la si possa anche dire guerra civile, cioè tra parti dello stesso gruppo politico, la loro guerra senza morti può essere più radicale, condotta più a fondo. Lo può perché è assicurata l’inviolabilità dei deputati, condizione essenziale della durata o della caduta del parlamento, che si “sbriciolerebbe” se qualcuno contasse sulla morte di un suo membro (p. 180).
La possibilità di congelare la morte all’interno di un conflitto radicale e permanente, ma simbolizzato, è tuttavia costantemente minacciata dall’interno stesso del sistema. L’aspetto istituzionale e formale, o più esattamente rituale, del conflitto introduce un elemento di distacco e mediazione che molti operatori politici hanno interesse a presentare come antidemocratico e nei cui confronti invocano l’intervento diretto e salvifico del popolo. Ma è pericolosissimo, ammonisce Escobar attualizzando Canetti, mettere in questione i numeri sacri dei voti elettorali o parlamentari cercando altrove – nelle piazze o nei sondaggi – una misura più adeguata e autentica della “volontà popolare”.
Tutto deve stare nei limiti del campo di battaglia del parlamento. Nel processo della decisione non deve entrare niente di quanto, prima della conta, si conosca della consistenza numerica dei partiti, e deve starne lontano quanto accada fuori del parlamento, si tratti di movimenti di piazza o di sondaggi. Se lo si facesse entrare – non di fatto, come può accadere, ma di diritto, invocandone la “democraticità” e dunque la legittimità – vi si introdurrebbero “numeri” non rituali che si vorrebbe modificassero il rituale contarsi per teste, e che sarebbero motivi di un rinnovato conflitto cruento e di un ritorno della paura della morte, la cui ombra non ha mai smesso di stare sullo sfondo (p. 181).
È stata una lunga e faticosa conquista, difficile da mantenere e facile da perdere, trovare la possibilità di “decidere senza uccidere” contando le teste senza tagliarle (pp. 171-195). Ed oggi appaiono, o ritrovano attualità, nuove minacce che la mettono in questione.
Una è quella di attribuire al “noi” una sostanza identitaria che per creare uguali crea diversi, e creandoli li respinge fino a sommergerli. La paura dello straniero proietta su di lui di ogni negatività presente all’interno dello spazio politico condiviso e dei suoi delicati e fragili criteri di commisurazione reciproca. Lo straniero è – ci appare, e dunque è – pericoloso non per ciò che realmente porta con sé, ma perché rivela con la sua sola presenza l’arbitrarietà, l’artificialità, l’assenza di necessità del nostro modo di costruire l’ordine.
Ci infastidisce, lo straniero. Pur nella sicurezza del luogo comune e delle differenze reciproche, pur nella reciproca vicinanza, ognuno di noi mantiene la distanza della propria singolarità, del proprio essere nel profondo ribelle ai legami e alle comunità. Che cosa fa la “varietà” dello straniero, se non portare evidente in sé e mostrarci la sua singolarità, e dunque la sua libertà dai vincoli della nostra abitudine? […]
In questo lo straniero ci infastidisce, in questo suo turbare la nostra banalità, in questo suo porsi ai nostri occhi come più libero, più ricco di umanità, sorprendente modello da imitare. In fondo, e per paradosso, lui guida il nostro desiderio: vorremmo essere come lui. Il fastidio può diventare inquietudine e paura, anche terrore. Quando accade, per liberarcene, o per illuderci di liberarcene, non ci resta che liberarci dell’altro che ci scandalizza. Liberarcene, negarlo come essere umano, è la condizione per essere (come) lui, al posto suo, sciolti dal peso di vincoli, doveri, altruismo sociale. Allora lo escludiamo (pp. 209-210).
Un’altra minaccia alla possibilità di continuare a mantenere il conflitto all’interno di un ordine simbolico che escluda la morte viene non dai confini varcati dallo straniero, ma dal centro stesso della nostra società, o dai suoi vertici. Non da oggi, ma dalle origini stesse della nostra attuale società esiste un conflitto irrisolto – e forse insolubile al suo interno – tra un ordine politico in linea di principio egualitario e un sistema economico che respinge strutturalmente l’idea di uguaglianza. E la disuguaglianza economica è sempre stata giustificata in un’ottica meritocratica. Gli uomini non sono tutti uguali: se i poveri sono poveri, e perché non meritano di essere ricchi. Non sono abbastanza operosi, non sono abbastanza virtuosi, non sono abbastanza intelligenti: in definitiva, non sono abbastanza umani. Un’ideologia che troviamo – esplicita e talvolta estrema – alle radici della rivoluzione industriale, ed è oggi rinnovata in chiave tecnocratica, monetarista e neoliberista. Le disuguaglianze non sono rimediabili, perché sono necessarie. La politica, che non le riconosce in linea di principio, non è per ciò stesso, non può essere l’istanza suprema dell’ordine sociale. L’ideologia centrale, il vero e proprio dogma su cui quest’ordine oggi si fonda è che la politica è subordinata al mercato, occupa lo spazio residuale se non illusorio che il mercato stesso le concede. In quest’ottica, la democrazia è accettabile solo a condizione che sia finta.
Quanto alla democrazia, peraltro ridotta alla messa in scena postdemocratica, la fatalità del nuovo potere nega di fatto legittimità al dissenso, magari facendone dichiarare a gran voce l’inopportunità dai mezzi d’informazione. Il conflitto, che dovrebbe essere ritualizzato e regolato, diventa un attentato alla unanimità richiesta dalla spoliticizzazione ideologica, secondo la quale non ci sono alternative a quanto “chiede” il mercato. Con la negazione, o anche solo con la riduzione del diritto al conflitto – sostituito dal fatalismo economico, ossia dalla ineluttabilità benefica dello scontro tra razionalità economiche in guerra tra loro -, viene negata la simbolizzazione della violenza, e insieme la ragione stessa della democrazia: la salvaguardia dei diritti (e delle teste) dei cittadini, siano in minoranza o in maggioranza (p. 243).
Escobar, naturalmente, non ha “soluzioni” da proporre, non è questo l’intento del suo libro. Che può essere considerato come il tentativo – affascinante e convincente – di creare un percorso narrativo, un racconto di concetti, che leghi l’attualità dell’uomo d’oggi all’universalmente umano che sta alle sue origini e alle sue permanenti radici. Dunque la conclusione – non la soluzione – è appunto questa. Si tratta di continuare il racconto, di non lasciarsi ingannare da chi vuol farci credere che ci resti solo da ripetere noi stessi in un presente immobile, senza futuro (pp. 225-250). C’è una leggenda ebraica narrata da Elie Wiesel. Il grande rabbino Baal Shem Tov, quando un pericolo minacciava il suo popolo, andava in un determinato posto in una foresta, accendeva ritualmente un fuoco, pronunciava una preghiera, e questo bastava ad allontanare il pericolo. I suoi discepoli a poco a poco dimenticano quale fosse il posto nella foresta, come si accendesse il fuoco, poi quale preghiera si dovesse pronunciare, infine quale fosse la foresta. L’ultimo di loro non sa fare più niente, sa solo raccontare. Eppure, dice Wiesel, anche questo continua a bastare. E così conclude anche Escobar:
Per il resto, non preoccupiamoci se non siamo capaci di accendere il fuoco, se non conosciamo la preghiera, se non ricordiamo quale sia il posto nella foresta, e neppure di quale foresta si tratti. Raccontiamone la storia. Dovrebbe bastare (p. 271).